PANTALONI PANT PANT

Live fast, recita la nuova pubblicità della Diesel.
E voilà, ecco la foto di una neo mamma postmoderna in corsa, che spruzza velocemente un po’ di talco sul culetto del suo bambino.
Mah.
Sarà perché penso che la cultura della fretta sia proprio quello che ci sta imbarbarendo, ma questa foto mi ha impressionato negativamente. Molto negativamente.
Non si tratta di fare del bieco tradizionalismo, ma di applicare un po’ di buon senso e mettersi nei panni (anzi, nei pannoloni) di quel povero pargoletto sballottato qua e là, alle prese con la sua nevrastenica mamma. Perché andare di corsa – mi spiace – non è un bel vivere. Proprio no.
Ma siamo nell’era dei Tutto intorno a te, dei Connecting people, dei Fastweb, delle comunicazioni globali in tempi reali.
Perché la mamma dovrebbe dunque salvarsi? Giusto.
Peccato che questa vita moderna – celebrata anche dalla Diesel- produca milioni di ipersterssati che fanno le fortune di psicologi, centri benessere, maghetti e apprendisti stregoni.
La fretta non è una virtù. Fretta significa superficialità, pressapochismo, incapacità di fissare quello che stiamo facendo.
Ma proseguiamo, proseguiamo nella magnificazione di questo falso mito.
E così anche le mamme adesso corrono con i loro bei pantaloni Diesel.
Il tempo rilassato del contatto con il bambino è scaduto, come uno yogurt conservato troppo a lungo nel frigorifero.
Ripeto: mah.
Dovremmo recuperare quel tempo prezioso che fa di noi degli esseri umani, e non degli automi efficienti efficaci produttivi organizzati.
Ma la neomamma che non ha tempo può consolarsi: archiviate le corse quotidiane, la sera può rilassarsi davanti al televisore, magari scegliendo fra Cogne di Vespa e la Rosa Bazzi di Matrix.
Cosa vuole di più dalla vita? Un Lucano.
LE COPERTE DI LINUS

Tutti abbiamo la nostra coperta di Linus.
Calda, familiare, confortevole, sta sempre lì. Se per caso si usura, eccoci pronti a crearne un’altra. Magari morbida morbida, più di prima.
E poi, poi senza copertina fa freddo.
Stare nudi davanti a noi stessi potrebbe provocarci una polmonite, esposti come siamo ai venti fracassoni dei nostri tormenti interiori, dei nostri limiti veri (e non di quelli presunti), delle nostre incertezze,
Se per caso proviamo a depositarla che accade?
Brr. Freddo. Tanto freddo. Voglio la mia copertina, Voglio ciucciarmi il ditino.
Ci sono persone e situazioni che rischiano di portarci verso la soglia di un abisso.
Quell’abisso in cui, nudi, precipitiamo in noi stessi.
E allora fuggiamo via, spaventati. Ci infiliamo di nuovo sotto la nostra copertina, cuciamo gli strappi, laviamo con Perlana i colori, cerchiamo di nuovo la sicurezza.
Quante coperte di Linus ci sono?
Tante. Moltissime.
Possono essere i vari fidanzati, focolari, lavori, viaggi, palestre di turno. Perfino le ricerche spirituali possono essere trasformate in copertine di Linus.
Ovunque si trovi la nostra sicurezza, lì sta la coperta.
Ce la mettiamo addosso cambiandola nel tempo inseguendo il mutare dei nostri bisogni, delle necessità.
Ma c’è sempre l’attimo spietato della verità. Quello in cui osiamo guardare davvero.
La copertina fatata delle nostre proiezioni allora cede, si sfilaccia, mostra l’usura. A quel punto, molti corrono a procurarsene un’altra. Altri, invece, restano al freddo.
Impauriti, incerti, tremanti, restano lì.
Senza coperte la vita fa male. A volte penso che crescere significhi semplicemente accettare il dolore di essere non come vorremmo – o immaginiamo – ma come siamo.
Ecco perché, alla fine, ci tiriamo fin sopra la testa la nostra bella copertina di Linus.
Spegniamo la luce. Buonanotte.
IL VENTO DENTRO

Ambrogio Fogar
Fin da piccolo il mare mi dava un brivido lungo la schiena. Forse era il sogno, la voglia di sfidare l’ignoto come i grandi navigatori che attraversavano l’oceano con i velieri piegati dal vento. Divoravo ogni romanzo con la speranza di vivere la stessa avventura: ce l’avrei fatta da solo, mi dicevo, con le mie forze. Perché avventura è mettersi alla prova, esplorare i limiti estremi della volontà e del cuore. L’avventura è corpo e spirito, braccia e gambe., ma anche luoghi impervi, sconosciuti, simbolici. Capo Horn, per esempio. La convergenza tra Atlantico e Pacifico, dove i gorghi delle correnti si alzano sferzati dal vento è il luogo dove puoi imparare a governare la paura. Davanti a quel promontorio di roccia nera e invisibile, nella notte, ci sei tu e il destino che ti guarda in faccia. Se passi, capisci dove può arrivare il tuo limite. (…). Dopo quella notte maledetta nel deserto del Turkmenistan riesco persino a sorridere e a scacciare la disperazione. Sono diventato come un neonato che non ha nessuna autonomia, ma che ha la conoscenza della vita. Se mi chiedono "Come stai"? rispondo così: sto come uno che ha la mosca al naso e non riesce a scacciarla via
(Ambrogio Fogar, Controvento)
La storia di Fogar mi ha sempre commosso e affascinato. Perché non ha mollato. Non ha mollato mai, neanche quando, costretto su una sedia a rotelle, misurava il soffitto della sua stanza che copriva i cieli stellati che gli avevano fatto da coperta nelle notti solitarie delle sue navigazioni.
Se l’è cercata, verrebbe da dire.
Sì. Se l’è cercata.
Ma ci sono persone che non se la cercano mai.
Di Fogar ho ammirato il coraggio folle che solo alcuni uomini possiedono, quello che ti fa dire sono incoscienti, spiritati, abitati da qualche demone inquieto.
Eppure queste migrazioni estreme, radicali, sfrontate, sono un luogo di sfida e confronto in cui soli, davanti alla Natura, ascoltiamo il nostro respiro.
Certo, si può anche viaggiare dentro e solcare altri mari, navigare negli oceani interiori fino alla soglia dell’abisso cosmico.
Ma di questi avventurieri, di questi capitani coraggiosi che non sono solo letteratura ammiro la ricerca della sottrazione, lo spogliarsi dei vestiti comodi che il progresso e le abitudini ci hanno cucito addosso. Il gusto della sfida titanica può nascondere ombre (ma chi non le ha?) che si mescolano però alle luci di albe dimenticate dal tempo, che un contatto selvaggio con la natura può far ritrovare intatte nella loro essenza.
Fogar ha pagato. Ma non si è pentito. E con lo stesso coraggio dei suoi viaggi ha anche affrontato il percorso più difficile, quello della memoria nell’immobilità.
C’è qualcosa di notturno e allo stesso tempo solare, in quest’uomo che voleva "prendere la vita a manciate", qualcosa che sfugge alla ragione che conserva il limite, il perimetro sicuro della sopravvivenza.
Se l’è cercata. Sì. Ma sarebbe tornato indietro, e avrebbe rifatto tutto.
Questo, il vero coraggio finale.
GLI UMORI DI UNA TERRA DOLENTE

Ci sono giorni in cui penso che questa terra forse non sarà più.
Accade spesso verso le soglie della primavera, quando nuova vita si affaccia alla vita.
E penso che mentre programmiamo le nostre vacanze, bravi bravi, tutti contenti, uno spicchio di ghiaccio si stacca per sempre. E penso che il sole irradia minacce. E che gli uccelli si smarriscono nelle loro sempre più fragili migrazioni.
Mi chiedo cosa possiamo e dobbiamo fare.
Poco, forse. O nulla.
Ma ciò che conta è l’averci provato.
Negli occhi piccini e golosi di vita del mio nipotino vedo riflessa una nuvola scura.
Vorrei soffiarla via, quella nuvola, vorrei essere vento e sgombrare il suo cielo acerbo, solcato da mille promesse, scortato dai giardini belli delle infanzie gloriose.
E mi chiedo quale infanzia, fra un secolo, sarà riservata ai figli dei figli.
Questa terra che muore si porta via un pezzetto di noi.
Ogni giorno.
SCRITTURE CONTEMPORANEE
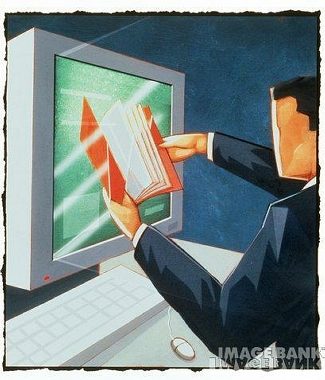
ONLINE IL NUOVO NUMERO DI SILMARILLON. SI PARLA, STAVOLTA, DI SCRITTURE CONTEMPORANEE.
Parlare di scrittura è sempre una faccenda articolata, complessa.
Scrivere lascia un segno, una traccia precisa (è per questo che da sempre l’uomo usa la scrittura per rendere eterno il suo passaggio su questa terra).
Ma il linguaggio è mobile, dinamico, condizionato dal tempo e dalla cultura.
Ogni periodo ha il suo “suono” particolare, ha parole “sue” che comportano un differente peso specifico.
Per questo folle di linguisti, filologi, letterati si sono sempre dati da fare intorno a quel sistema meraviglioso, terribilmente affascinante quanto complicato rappresentato dalla parola scritta.
Chi lavora con le parole sa quanto queste siano birichine, sfuggenti, rapide. Mercuriali.
Da quando l’uomo antico ha codificato i primi segni, a a quel tempo composti da grafìe mi animaliste che tuttavia già prevedevano un profondo sistema simbolico-filosofico, la parola – intesa in questo senso come significato condiviso di nomi riconoscibili – ha accompagnato, fin dall’aurora del tempo, lo sviluppo e l’estensione dell’uomo su questo pianeta. Dare in nome alle cose significa farle vivere, farle esistere. Ecco perché Adamo nomina, man mano, le piante e i fiori. Allo stesso modo, in Australia, i primi abitanti – nati, secondo la leggenda aborigena, dalla terra – cominciarono a camminare cantando il mondo, nominando ciò che via via incontravano. Le vie dei canti, le vie dei suoni, le vie delle parole.
E oggi?
Oggi che succede? Non è più solo il tempo del libro su carta, libro che da Gutenberg in poi ha rappresentato il mezzo sublime di conoscenza e trasmissione del sapere, quello capace di soppiantare ogni altra forma (come fa dire anche Victor Hugo a uno dei protagonisti nel suo Notre-Dame de Paris).
Oggi è il tempo della televisione, dei computer, delle chat, degli sms.
La comunicazione si fa immediata, diretta, rapida.
La scrittura squisitamente sofisticata, virtuosa di un Proust, con i suoi periodi di dieci righe densi di maestose subordinate, che senso ha, oggi?
Ha senso, ha senso. Eccome se ce l’ha.
Intanto non dimentichiamo mai che i classici vivono eternamente. “Un classico è un libro che non ha mai finito di dire quel che ha da dire” scriveva Calvino. E aggiungeva: “È classico ciò che persiste come rumore di fondo anche là dove l’attualità più fa da padrona”.
Dunque un Dante, un Checov, un Jack London e un Balzac saranno sempre attuali, sempre presenti.
Il problema, semmai, si pone per chi decide di scrivere adesso.
La nostra società ha scarnificato il linguaggio, certamente lo ha anche omologato, in qualche modo, come intuiva – e giustamente denunciava – Pierpaolo Pasolini.
Eppure, eppure la lingua è capace di saltare ogni schema, ogni struttura. La lingua è alata, come Mercurio. Si tratta di osare quel tuffo capace di produrre una scrittura personale, caratterizzata dall’impronta di un’individualità.
I nostri tempi moderni sono ancora in grado di produrre buone scritture.
Scritture diverse, versatili come versatili sono i mezzi di comunicazione.
L’appiattimento socio-culturale è un’altra faccenda di cui, ovvio, anche la scrittura – in quanto sua espressione – risente.
Ma possiamo ancora inciampare in libri bellissimi, capaci di stupirci.
O in libri meno folgoranti e tuttavia pregevoli, capaci di trasmetterci comunque qualcosa.
Alcuni studiosi del linguaggio sostengono che i media abbiano influito negativamente sulla scrittura, altri invece ne esaltano aiuti e possibilità.
All’interno del dossier troverete varie scuole di pensiero. Non a caso.
Silmarillon è un progetto trasversale, che ama il dubbio, il punto interrogativo. Che all’affermazione preferisce la domanda, all’assoluto la possibilità.
Anche in questo caso, dunque, le strade sono aperte, i pensieri si intercettano, si sovrappongono, camminano parallelamente e in alcuni punti di dividono. Va bene così.
Sicuramente la quantità di scrittura è aumentata notevolmente (basta pensare ai blog, tanto per fare un esempio, oggi setacciati dagli editori in cerca di nuovi scrittori).
Forse è la qualità ad essere piuttosto carente, a volte. Ma questo problema non appartiene solo alla scrittura. È, semmai, una minaccia diffusa in questo secolo così fragile, a volte, perché afflitto dagli eccessi della quantità. .
Gli imputati sono la superficialità, la globalizzazione in cui spesso prende forma l’ assenza di discriminazione, la bulimia crescente che tutto fagocita e nulla digerisce (pericolo presente in tutti campi), la voglia di evadere piuttosto che di scavare, sudando, sudando.
E la scrittura richiede sudore. Comunque.
Non importa se la mano che la guida impugna la penna d’oca di un romanziere ottocentesco oppure digita con agio una sfilza di parole sul pc di casa.
L’impegno che la parola ci chiede è senza tempo. Un po’ come i classici.
Che poi mezzi siano molteplici, che siano più immediati, che rendano tutto più fluido e facilmente raggiungibile è un’altra faccenda.
Senza sforzo non ci sono parole (l’ispirazione, quella sorta di felice sorella tche ti attraversa facendo balenare le giuste frasi nel giusto tempo si accompagna sempre e comunque a rallentamenti, a contrazioni del linguaggio in cui la ricerca si fa più difficile. E sempre, sempre, il lavoro di lima e cesello è necessario per raffinare quanto si è scritto).
Le scritture contemporanee, in più, hanno il dovere – a mio avviso – di raccontare il nostro tempo.
Troppo spesso chi scrive si rifugia nel passato, si rannicchia in moti intimisti, autobiografici, predilige schemi sentimentali sempre uguali a se stessi.
La nostra società ha un bisogno disperato di essere raccontata. E allora ben vengano i Saviano, i Rizzo e gli Stella.
Ma ben vengano anche le Tina Spacey, i Clifford Chase, i Veronesi, solo per fare una manciata di nomi.
Insomma, raccontare la contemporaneità si deve, si può.
Travestendola da finzione oppure così, tout court, senza troppe mediazioni al di là di una forma romanzata che la renda più godibile, suadente.
La tentazione di rimpiangere i classici a volte è forte, a volte si fa tensione estrema, radicale.
Ma cercando si trovano tante piccole perle. Che saranno, magari, i classici di domani.
L’importante è fiutare quel vento lieve che solleva le parole dalla contingenza e le trascina ai confini della materia. Ecco che lì, in quel luogo, la scrittura non ha né presente né passato. Semplicemente, è.
GLI OCCHI DELLA MORTE

Verrà la morte e avrà i tuoi occhi
questa morte che ci accompagna
dal mattino alla sera, insonne,
sorda, come un vecchio rimorso
o un vizio assurdo. I tuoi occhi
saranno una vana parola,
un grido taciuto, un silenzio.
Cosí li vedi ogni mattina
quando su te sola ti pieghi
nello specchio. O cara speranza,
quel giorno sapremo anche noi
che sei la vita e sei il nulla.
Per tutti la morte ha uno sguardo.
Verrà la morte e avrà i tuoi occhi.
Sarà come smettere un vizio,
come vedere nello specchio
riemergere un viso morto,
come ascoltare un labbro chiuso.
Scenderemo nel gorgo muti.
(Cesare Pavese)
Oggi la morte ha per me degli occhi precisi. Sono azzurri, accesi dal guizzo scintillante dell’intelligenza che sempre si affaccia dietro uno sguardo sottile.
E ha pure occhi marroni, gli occhi marroni di un domani prossimo, troppo prossimo, che ansima su una vita definita dalla malattia che ne stacca a morsi i secondi.
Ma, in fondo, la morte ha anche i miei occhi. E quelli di ognuno di noi.
In questo pomeriggio piovoso, sospeso fra lutti appena passati e lutti annunciati, tutto sembra ridimensionare ogni pretesa, ogni miseria, ogni traguardo.
Perché la morte ti sbatte in faccia la tua finitezza, e tu stai lì, piccolino, ridicolo, aggrappato alle tue certezze che hanno la stessa consistenza di un soffio.
Del resto, lei è l’unica, incorruttibile sicurezza.
Tutti siamo destinati a morire. Delle altre cose, dei sogni, delle glorie, delle varianti applicate alla nostra sorte nulla, in effetti, sappiamo. Possiamo congetturare, sperare, inseguire…Ma ogni cosa, ogni attimo, vive sul filo dei mutamenti e noi, noi come acrobati attraversiamo in punta di piedi- un passo dopo l’altro – la linea sottile dell’esistenza. Avanziamo a volte tremanti, altre volte spavaldi.
Ma solo una cosa rende uguali le nostre storie, solo una cosa assottiglia le varianti dei nostri destini fino a renderci tutti simili, tutti uguali. Solo la morte – vera, irrevocabile democrazia- rappresenta l’unica sicurezza, l’unica condivisione di una meta comune, irreversibile.
E dobbiamo imparare a guardarla in faccia, questa morte.
E quanto è difficile, in questo circo pieno di forme e colori, denso di promesse di gloria e di giovinezza, di scommesse sul trionfo dell’uomo che ritarda la morte – ritarda, ma non annulla – di morti mediati dalle televisioni oppure rintanati negli ospizi e negli ospedali, quanto è difficile, sì, ricordarsi ogni giorno che dobbiamo morire.
Già, perché la morte rende ogni cosa transitoria, fragile, traballante. Ma senza di lei non ci sarebbe la vita, quella stessa vita che diciamo di amare tanto. E tuttavia, come sempre, amiamo solo ciò che non ci spaventa, incapaci di accettare l’orrore dell’interezza.
Siamo piccini. E impauriti.
Davanti alla morte ogni soluzione di continuità si infrange come l’onda su uno scoglio.
Ma, dentro, in mezzo al dolore e alla disperazione la coscienza continua a pulsare.
Non a caso quando perdiamo qualcuno detestiamo i luoghi chiassosi e le ciance inutili.
La morte chiede silenzio, e verità.
Così, all’improvviso, accanto a noi vogliamo solo chi è davvero importante. Ci nutriamo di affetti veri mentre gli altri, quelli di circostanza, diventano incommestibili, come cibo scaduto. Li scansiamo come fanno i cavalli con le zanzare.
Perché il dolore fa chiarezza, purtroppo. Rende ancora più importanti le cose importanti, e inutili quelle che invece trasciniamo per convenienza, o bisogno. Mette a nudo le zavorre, scarnifica l’anima.
La morte muta equilibri, sposta scenari e confini.
E il mondo finisce sullo sfondo, e se ne sta lì, con i suoi rumori, le sue luci, le sue corse e i suoi progetti.
Guardo fuori dalla finestra, e ancora e ancora.
La malinconia si fa uggiosa, come questa giornata. Ma allo stesso tempo insegna. Insegna come insegna la morte stessa. E noi continuiamo a scansarla, a esorcizzarla finché un giorno, all’improvviso, lei ti ricorda che c’è.
E lo fa modo suo. Senza tanti preamboli o tanti preavvisi.
Non si schiera, non discrimina, non ha preferenze o avversioni.
La grande signora della democrazia non fa sconti né accetta la vendita delle indulgenze.
Ma allora perché facciamo finta che non ci sia? I popoli antichi la trattavano con più rispetto.
Memento mori.
Quanta saggezza.
Ricorda che ogni successo è destinato a terminare, ricorda sempre che esiste un passaggio e che è meglio che tu ti prepari.
Gli estremi della vita, la nascita e la morte, sono segnati dal trauma della solitudine in un passaggio difficile, estremo, che cambia sostanza e forma al nucleo di cui siamo fatti.
Celebriamo la vita ma ignoriamo la morte.
E invece penso che dovremmo avere il coraggio di guardare i suoi occhi. Sapere che dovremo affrontarla, che ci toglierà affetti e amori ma che, nello stesso tempo, ci regalerà i suoi amari frutti.
Non si impara solo assaggiando il nettare dolce. Si impara soprattutto dal dolore. Si impara dall’amputazione di quella falce che sottraendo allo stesso tempo consegna. Che cosa, è faccenda privata per ognuno di noi.
Ma tutti scenderemo nel gorgo muti.
E lì, in quel momento, al di là del respiro e delle parole, al di là della mente e di ogni teoria, misureremo esattamente ciò che siamo stati capaci di essere.
Pagina 49 di 83

